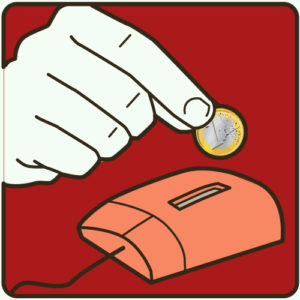Parlando con nessuno

C’era una volta uno che mi dava una pena raccontandomi perché stava soffrendo. Il perché non era chiaro, il perché soffrisse, intendo. Stavamo seduti in macchina, lui da una parte e io dall’altra, sotto casa sua. Gli davo uno strappo dopo il lavoro.
C’eravamo trovati a fare un lavoro, lo stesso lavoro fesso. E voleva che non lo lasciassi solo. Gli restava di tornare a casa con un mezzo, e questo lo rendeva triste, a stare al freddo con un abbonamento scaduto. Così, scaduto e solo, diceva. Lo ascoltavo durante il viaggio, ci provavo ma non capivo. No, non capivo. Gli ripetevo di raccontarmi i fatti, di nuovo. Cercavo di stare attento, ma ogni volta attaccava piano come stesse facendo vibrare la lingua fra i denti e le labbra. Tanto che mi mettevo a fare lo stesso, mentre lui andava avanti sempre più piano, più piano, in un bisbiglio basso fino a morire, fino a dormire.
Forse era la storia di una, ma non saprei, una con cui era stato un pezzo, ma non so. Una che assomigliava a un’altra e che se ne era andata, diceva, ma che l’altra non era quella che c’era e lui questa non la voleva, come l’altra quando c’era. Non so, non capivo. Parlava piano, troppo piano. Quando pensavo che stesse per finire, quando le parole erano diventate come una lunga e indistinguibile nota bassa, gli si impennava la voce di botto e io mi svegliavo sbattendo la testa sullo sportello, sul vetro, la tempia, un colpo. E lui, preso da quella cosa, diceva con agitazione, con un enorme gesto della mano, una mano più grossa del corpo, che pareva diventare tutta la sua mano il suo corpo, diceva che non era giusto che lui stesse così male, che un tempo era bello, bravo e in gamba, e cose così, e che io gli dovevo credere. Uno capace di grandi gesti insomma, gesti enormi, enormi mani. E lo diceva con l’indice all’aria come fosse in un’aula, come un processo, una sentenza, non so, giurava. Poi, al culmine della gran mano, del giuramento: silenzio. Ridacchiava nervoso, e guardandomi con la faccia di uno, uno che non si piace per niente in realtà, sospirava, e sospiravo.
Aveva una gran massa di capelli ricci, mi distraevano quei capelli, non so, forse era quello. Stavano tutti montati da una parte, come stessero per crollare, e si muovevano al ritmo dei suoi sussulti, delle sue parole, di quel bisbiglio vibrato piano, nel controluce smorto fra il cruscotto e il finestrino, a disegnare cerchi. Cerchi di capelli. Si aggiustava quella parrucca continuamente come fosse un cappello, e gesticolava facendo quella specie di tremito, ritornando sulla questione che era bello, capace di grandi gesti, gesti giurati, enormi. Poi rimaneva zitto e io pure. Guardavamo davanti la strada, in silenzio, sotto casa sua. Una strada piena di freddo, di odore di fritto, spenta dopo il lavoro. Una strada lunga contro un muro, dopo un incrocio, un muro. Una serie di palazzi, zitti pure quelli, chiusi a uncino e un muro.
Io aspettavo che scendesse, lui rimaneva fermo. Un uomo fumava una sigaretta sotto il portone, ogni sera, aspettando che il proprio cane pisciasse e facesse il resto. Fatto tutto, gli faceva fare quattro giri di strada, a quel cane secco, secco al freddo.
Quattro giri uno dietro l’altro, pochi metri avanti e indietro, ogni volta solo quelli. Li contavo, accendevo le quattro frecce della macchina, la mia macchina rotta, che se le accendi si incantano e pure se vuoi spegnerle, non si spengono. E aspettavo. Uno, due, tre, quattro e il ticchettio delle frecce. Al quarto giro del cane, delle quattro frecce incantate, preciso al quarto, sempre, accanto a me quello: urlava. Urlava proprio quando mi ero assopito, incantato al quattro. Sotto casa, dentro la mia macchina con le frecce, col cane che pisciava e il resto, con l’uomo che fumava e aspettava di raccogliere quella merda, lui rivolto a lei, una che non c’era, ripetendo tutto il punto in cui un tempo era bello e bravo e in gamba: urlava. E lo giurava, come io non dovessi credere quella cosa di lei e di tutto il resto, che non voleva rimanere solo, solo dopo il lavoro, il nostro lavoro fesso, perché non era giusto. Lui, scaduto e solo. Ma non riusciva a sentire niente, niente che io gli potessi dire, ripeteva soltanto che – credo, perché non ne sono più sicuro – ripeteva soltanto che: prima era in un modo e poi non lo è stato più, a quel modo. Il punto che a me spiaceva e io ci provavo a dire delle parole, prima delle frasi vere, poi finte, poi assurde, infine a caso. L’ho ascoltato per un po’, lo confesso, poi mi sono messo a dormire. E basta. Per un anno forse o forse di più, a portarlo avanti e indietro, quattro giri, quattro frecce, l’urlo e poi raccogliere.
Un giorno a lavoro, al nostro lavoro fesso, uno gli ha tirato un calcio nel culo. E lui piangendo diceva che non era giusto, ancora. Anche un calcio nel culo adesso? Ma pareva che era bello quel calcio, perché rideva mentre piangeva. E io non capivo.
Non capivo e gli chiedevo: ma è giusto o no? Stai male o no?
Non lo so, l’ho lasciato in una strada a uncino, contro un muro, a un incrocio, di un cane che piscia e un uomo che fuma sotto casa. Poi una volta è passato in motorino, una vespa, la sua vespa nuova, io stavo a piedi. Non si è fermato. Grandi gesti, grandi mani. Mi ha gridato qualcosa, non so bene che, io ero a piedi, ero stanco, non ho capito. Non si è fermato. Merda! Andava da quello che gli aveva dato un pedata nel culo. Quando mi sono fatto la salita a piedi li ho visti, seduti al bar a parlare.
E lui era contento. Migliore amico di un calcio al sedere, ho pensato. Da quel giorno non mi ha più parlato, aveva trovato uno che gli dava quello che gli ci voleva. E io mi sono fatto tutta la salita a piedi.