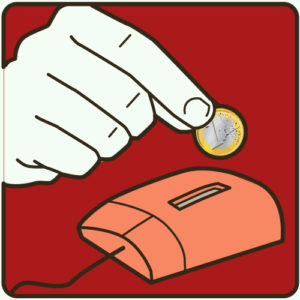Stabat Mater

I
Ci sono mattini trasparenti, prima che il cielo si rannuvoli e il tempo si guasti. Ci sono mattini trasparenti in cui l’isola appare. Una lingua di terra si ingobbisce sull’acqua, al largo della costa. Giovanni dice che un giorno andremo ad abitare lì. Non appena mi sarò ripresa, noleggerà una barca, vi porteremo le nostre cose e finalmente avremo un po’ di pace.
Faccio sì con la testa per non scontentarlo e lascio che ritorni alle sue carte. Spesso lo sento borbottare, come un vecchio. E dire che non ha ancora quarant’anni. Si affatica con le lettere, le fa ricopiare da un ragazzo e, quando le rilegge ad alta voce, batte i pugni sul tavolo.
A me sembra uno sforzo inutile incatenare le parole sulla carta: le cose che diceva, le cose che non diceva, le cose che mai avrebbe detto.
Cosa resta di un uomo? Restano le parole. Restano le azioni. Ma i pensieri, quelli che confessa a se stesso e a nessun altro, spariscono con lui.
A sera, sul muro bianco di calce, l’ombra di Giovanni trema alla luce della lanterna. La sua ombra trema, lui no. Lui fissa un angolo della stanza, del tutto immobile. Poi da mare sale il brusio della risacca insieme ai suoni della città che si appresta al sonno.
II
Siete stanca, madre?
Mi accorgo di essermi assopita e la domanda di Giovanni mi fa trasalire. Ora tutti mi chiamano madre. Come è facile confondere i giorni, i mesi e gli anni intorno a una fiammella che brucia nel buio. Il buio racconta ciò che non è più: la tua schiena curva, sulla quale piovono scomposti i capelli nerissimi mentre con un panno ti asciughi le mani, sullo scanno i barattoli in fila con l’orlo sporco di colla, le lame dentate appese alla trave che attraversa il soffitto. Sussulti. Una scheggia minuscola si è infilata sotto pelle. Non vuoi che ti aiuti. Vuoi fare da solo e ridi della mia apprensione. Sei un giovane uomo e ogni tua premura per me è sempre anche un rimprovero. Tuo padre ci osserva in silenzio. Lascialo stare, mi dice senza parlare. Lascialo andare, mi ripete ogni giorno senza proferire parola.
Non è diversa dalle altre, la nostra famiglia. Nei silenzi misuriamo distanze e consumiamo avvicinamenti. Nei silenzi sorvegliamo i mutamenti che si riconoscono solo quando sono compiuti.
E così accade che un giorno mi sorprendo a cercare nel tuo sguardo il presagio dei giorni che verranno, come fa ogni madre, scacciando la paura come un cattivo pensiero; il cupo di una nube che si avanza copre il cielo sull’umida pupilla: è forse solo l’ombra delle ciglia, lunghissime, con cui proteggi te stesso e me, e ora anche tuo padre, avvolto nel sudario sul pancaccio al centro della stanza, dove il volo istupidito di una mosca ripete aureole stanche.
Poi ti carichi in spalla la bisaccia e dici: io vado via. Non ti chiedo dove. Tutto si compie. E’ già compiuto. Sotto l’asola della porta un refolo di polvere cancella i tuoi passi, sospira e mi chiama per nome: Maria, Maria, Maria.
III
La voce mi riporta al vecchio pozzo. Sono una ragazza di quindici anni che tira su il secchio: sul fondo il bagliore del sole capovolto, il raspo della fune sulla pietra, la sciocca filastrocca che cantano i bambini nel cortile: ha scelto te, ha scelto te, ha scelto te.
Il rigurgito batte contro i denti, la primavera ha un sapore rancido che vorrei ricacciare in gola con il dorso della mano. So di essere incinta. So di averti voluto. Ecco, tutto si compie, tutto è già compiuto. Ti ho partorito al mondo, figlio mio.
Lascio scorrere l’acqua nel lavatoio. La sento zampillare sul bordo delle stoviglie, la sento tintinnare sul vetro del bicchiere. Lo scroscio riempie la casa vuota. Mi aggiro per le stanze, apro gli armadi, rifaccio il letto. Mi sforzo di rimettere ogni cosa al suo posto e mi ritrovo, invece, a mettere in scena il disordine, a disseminare intorno le tracce di una presenza fittizia, la tua. Senza che davvero lo voglia, m’illudo che tu sia ancora qui.
Mi parlano di te: all’angolo delle strade, nelle botteghe, sull’uscio della porta. Di giorno in giorno mi abituo a sentire parlare di te. Sarebbe tutto più semplice se imparassi a credere che nei loro discorsi non ci fossi tu, ma un altro te che predica e guarisce e che raduna folle. Anche nel più inverosimile dei racconti, anche nella più malevola delle calunnie sul tuo conto, spero in un dettaglio, sfuggito, insignificante per altri, un dettaglio in cui riconoscere qualcosa di quel figlio che andò via con la bisaccia sulla spalla senza voltarsi indietro.
Mi metto in viaggio anche io, e vengo a cercarti.
IV
E’ sua madre, sussurrano. E’ sua madre. Lasciatela passare. Mi indicano e si scostano. Mi avvio su per la montagna. Intravedo in alto la cima di un albero e mi fermo ad ascoltare il brusio delle foglie. Non riconosco il fruscio della tua voce che seduce finché non sono lì a pochi passi. C’è tua madre, ti dicono. Ci sono i tuoi fratelli. La deferenza con cui mi annunciano mi inquieta, mi allontana da te, mi sospinge oltre il cerchio che hai tracciato con un ramo sullo sterro.
Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Allunghi la mano in direzione opposta alla mia e la fai ruotare sui presenti. Ecco mia madre ed ecco i mie fratelli, dici.
Io vado via. Mi attende la corriera per il ritorno a casa.
Trattengo in un pugno il lembo del manto che mi protegge dal mezzogiorno, nell’altro il mistero della severità con cui mi accogli. Sul finestrino m’interroga il riflesso di una donna sfiorita che non sa più chi è.
V
Se voglio ancora essere tua madre, devo accettare di essere la madre di tutti.
E così sia. Ora sono la madre di prostitute e gabellieri, di pubblicani, storpi, adultere e ladroni. Credono in te perché li hai guariti. Li hai guariti perché credono in te. Ma a ciascuno hai rivelato lo sgomento di essere al mondo e per questo, un giorno, non ti perdoneranno.
Si tolgono i pastrani e li stendono ai tuoi piedi; si liberano dei mantelli, delle giacche, degli scialli. Un fiume di stracci straripa e scorre verso la Città delle Città, dietro l’uomo che cavalca un’asina, il Maestro. Tutti acclamano il tuo passaggio. Chissà se l’asina avverte il pericolo, come sanno fare le bestie, e recalcitra. O forse anche essa obbedisce al disegno e, docile, asseconda il movimento che ti conduce verso la fine.
La folla che ti applaude mi spaventa. Mi turba l’euforia dei tuoi giovani amici. Sono soggiogati dalle tue parole, ma non le hanno comprese. Persino Giovanni, che ti ama. Non gli basta l’amore per capire fino in fondo dove ti porterà questa ansia di salvare tutti tranne te stesso. Se solo lo intuisse, sparirebbe il sorriso spavaldo con cui mi racconta dei tuoi successi.
Perché ciò che ci unisce, figlio, finisce per separaci, e ciò che ci separa ci unisce ancora di più: tra me e te ci sono le voci dei tanti che chiedono grazie, le voci dei troppi che non disperano più.
Sono le stesse voci che annunciano il tuo arresto: la notizia corre di bocca in bocca e gonfia il ventre della città che è il vuoto del mio grembo di vecchia. Mi afferro la pancia con entrambe le mani, come se avessi di nuovo le doglie, e, quando rialzo il capo, sei già sulla croce, irriconoscibile: ancora una distanza, l’ultima, vertiginosa distanza.
L’odore dolciastro del sangue dà alla testa. Sotto l’albero spoglio che chiamano croce la calma stordisce, rallenta i gesti, sospende i respiri. Ogni tanto qualche soldato interviene e svolge il suo compito con un’efficienza svogliata che mi scuote: dunque è tutto vero? Era proprio questo che volevi? Finire come l’ultimo dei delinquenti? Non mi rispondi. Ancora una volta non mi rispondi.
VI
Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli.
La folla si disperde, Maddalena si strappa i capelli, Giovanni singhiozza. E allora capisco: quel che resta di mio figlio è un misero scorzo contro il cielo. Eppure quando ti schiodano dall’azzurro, precipiti dall’alto, mi cadi addosso e il tuo peso mi schiaccia a terra. Un ultimo sforzo per scacciare le mani che si protendono, le braccia che vorrebbero sollevare il tuo corpo, che vorrebbero portarti via.
Premo la bocca sul costato, sul collo, sulla spalla, come fa ogni madre che sana la ferita con un bacio. Mi accanisco perché sento ancora una vena di tepore e invece è solo la forza con cui mi stringo a te.
Tutto germoglia al sole e sboccia ogni cosa, e il vento di primavera porta fino a quassù l’allegria spensierata con cui si chiudono le botteghe perché domani in città è un giorno di festa.
Il mondo ci volta le spalle, figlio, e io la benedico, questa vile e disumana indifferenza, perché per pochi, brevissimi istanti, finalmente ci siamo solo io e te.
VII
Ci sono mattini di densa foschia, prima che la calura si dissolva. Ci sono mattini di densa foschia in cui l’isola scompare. L’orizzonte bianco e sconfinato ci smarrisce. Giovanni lascia le sue carte e si affaccia sull’uscio della porta. Mi poggia una mano sulla spalla, come a chiedermi scusa. Come se fosse sua la colpa di quella sparizione. Il ragazzo sale dalla riva. Ha i piedi sporchi di sabbia. Mi porge una conchiglia e mi dice: Madre, ascolta. Si sente il mare.
Accosto il guscio all’orecchio e chiudo gli occhi. Il mare è in tempesta, il fragore delle acque si mescola alle grida di chi cerca aiuto e non lo trova. E così ascolto di nuovo la tua voce, figlio mio.